E si volse per andarsene; diede qualche passo incerto, vacillante; poi si affrettò, uscì dalla stanza, seguita da mia madre.
Io le guardai allontanarsi per la fuga delle porte, ancóra tenuto da un resto della sensazione primitiva, trasognato.
II
La mia confidenza nell’avvenire aumentava di giorno in giorno. Non mi ricordavo quasi più di nulla. La mia anima troppo affaticata si dimenticava di soffrire. In certe ore di completo abbandono tutto si dileguava, si distendeva, si fondeva, si immergeva nella fluidità originale, diveniva irriconoscibile. Poi, dopo questi strani dissolvimenti interiori, mi pareva che un altro principio di vita entrasse in me, che un’altra forza mi possedesse.
Una moltitudine di sensazioni involontarie, spontanee, inconscienti, istintive componeva la mia esistenza reale. Tra l’esterno e l’interno si stabiliva un giuoco di minime azioni e di minime reazioni istantanee che fremevano in infinite ripercussioni; e ciascuna di queste ripercussioni incalcolabili si convertiva in un fenomeno psichico stupendo. Tutto il mio essere veniva alterato da ciò che passava nell’aria, da un soffio, da un’ombra, da un bagliore.
Le grandi malattie dell’anima come quelle del corpo rinnovellano l’uomo; e le convalescenze spirituali non sono meno soavi e meno miracolose di quelle fisiche. Davanti a un arbusto fiorito, davanti a un ramo coperto di minute gemme, davanti a un rampollo nato su un vecchio tronco quasi estinto, davanti alla più umile fra le grazie della terra, alla più modesta fra le trasfigurazioni della primavera, io mi soffermavo, semplice, candido, attonito!
Uscivo spesso con mio fratello al mattino. In quell’ora tutto era fresco, facile, libero. La compagnia di Federico mi purificava e mi fortificava come la buona brezza selvaggia. Aveva allora ventisette anni Federico; aveva vissuto quasi sempre nella campagna, d’una vita sobria e laboriosa; pareva portare in sé raccolta la mite sincerità terrestre. Egli possedeva la Regola. Leone Tolstoj, baciandolo su la bella fronte serena, lo avrebbe chiamato suo figliuolo.
Andavamo per i campi senza mèta, di rado ragionando. Egli lodava la fertilità dei nostri dominii, mi spiegava le innovazioni introdotte nelle culture, mi mostrava i miglioramenti. Le case dei nostri contadini erano larghe, ariose, linde. Le nostre stalle erano piene di un bestiame sano e ben pasciuto. Le nostre cascine erano in un ordine perfetto. Spesso, nel cammino, egli s’arrestava per osservare una pianta. Le sue mani virili erano di una delicatezza estrema quando toccavano le piccole foglie verdi in cima ai rametti novelli. Talvolta passavamo attraverso un frutteto. I peschi, i peri, i meli, i ciliegi, i prugni, gli albicocchi portavano su le loro braccia milioni di fiori; giù per la trasparenza dei petali rosei ed argentei, la luce si cangiava quasi direi in una umidità divina, in una cosa indescrivibilmente vaga e benigna; tra i minimi intervalli delle ghirlande leggere, il cielo aveva la vivente dolcezza di uno sguardo.
Egli diceva, imaginando il pensile tesoro futuro, mentre io lodavo i fiori: – Vedrai, vedrai i frutti.
“Io li vedrò” ripetevo dentro di me. “Vedrò cadere i fiori, nascere le foglie, crescere i frutti, colorirsi, maturarsi, distaccarsi.” Questa assicurazione, già passata per la bocca di mio fratello, aveva per me un’importanza grave, come se si riferisse a non so quale felicità promessa e attesa, la quale appunto dovesse svolgersi in quel periodo del parto arboreo, nel tempo che corre tra il fiore e il frutto. “Prima che io abbia manifestato il mio proposito, a mio fratello par già naturale che io rimanga ormai qui, nella campagna, con lui, con nostra madre; poiché egli dice che io vedrò i frutti dei suoi alberi. Egli è sicuro che io li vedrò! Dunque è proprio vero che è incominciata una vita nuova per me, e che questo sentimento ch’io ho dentro di me non m’inganna. Infatti, tutto ora si compie con una facilità strana, insolita, con un’abbondanza d’amore. Come amo Federico! Non l’ho mai amato così.” Tali erano i miei soliloquii interiori, un po’ slegati, incoerenti, qualche volta puerili per una singolare disposizione d’animo che mi portava a vedere in qualunque fatto insignificante un segno favorevole, un pronostico benigno.
Il gaudio mio più intenso era nel sapermi lontano dalle cose passate, lontano da certi luoghi, da certe persone, inaccessibile. Assaporavo talvolta la pace della campagna primaverile raffigurandomi lo spazio che mi divideva dal mondo oscuro dove io avevo tanto sofferto e di dolori tanto cattivi. Una paura indefinita mi stringeva ancóra, talvolta, e mi faceva cercare con sollecitudine intorno a me le prove della sicurtà presente, mi spingeva a mettere il braccio sotto il braccio di mio fratello, a leggere negli occhi di lui l’affetto indubitabile e tutelare.
Io confidavo in Federico, ciecamente. Avrei voluto essere da lui non soltanto amato ma dominato; avrei voluto cedere la primogenitura a lui più degno e star sommesso al suo consiglio, riguardarlo come la mia guida, obedirgli. Al suo fianco non avrei più corso il pericolo di smarrirmi, poiché egli conosceva la via diritta e camminava per quella con un passo infallibile; ed egli anche aveva il braccio possente e mi avrebbe difeso. Era l’uomo esemplare: buono, forte, sagace. Nulla per me uguagliava in nobiltà lo spettacolo di quella giovinezza devota alla religione del “conscientemente bene operare”, dedicata all’amore della Terra. Parevano i suoi occhi aver assunto un limpido color vegetale dalla contemplazione assidua delle cose verdi.
– Gesù della Gleba – io lo chiamai un giorno, sorridendo.
Era un mattino pieno d’innocenza, uno di quei mattini che dànno imagine delle albe primordiali nell’infanzia della Terra. Sul limite di un campo, mio fratello parlava a un gruppo di agricoltori. Parlava in piedi, avanzando di tutto il capo gli astanti; e il suo gesto calmo dimostrava la semplicità delle sue parole. Uomini vecchi incanutiti nella saggezza, uomini maturi già prossimi al limitare della vecchiaia ascoltavano quel giovine. Tutti portavano su i loro corpi nodosi la traccia della grande comune opera. Poiché nessun albero era da presso, poiché il frumento era umile nei solchi, le loro attitudini apparivano integre nella santità della luce.
Come mi vide muovere verso di lui, mio fratello licenziò i suoi uomini per venirmi incontro. Allora spontanea mi uscì dalle labbra la salutazione:
– Gesù della Gleba, osanna!
Egli aveva per tutti gli esseri vegetali una diligenza infinita. Nulla sfuggiva alle sue pupille acute, quasi onniveggenti. Nelle nostre corse mattutine, si soffermava ad ogni tratto per liberare da una chiocciola, da un bruco, da una formica una piccola foglia. Un giorno, senza badarci, camminando, battevo le erbe con la punta del bastone; e le tenere cime verdi recise ad ogni colpo s’involavano. Egli ne soffriva perché mi tolse di mano il bastone ma con un gentile atto; ed arrossì, pensando forse che quella sua misericordia mi sarebbe parsa una esagerata morbidezza sentimentale. Oh quel rossore su quel volto così maschio!
Un altro giorno, mentre spezzavo a un melo qualche ramo fiorito, sorpresi negli occhi di Federico un’ombra di rammarico. Sùbito tralasciai, ritrassi le mani, dicendo:
– Se ti dispiace…
Egli si mise a ridere forte.
– Ma no, ma no… Spoglia pure tutto l’albero.
Intanto il ramo già rotto, ritenuto da alcune delle sue vive fibre, penzolava lungo il fusto; e, proprio, quella frattura umida di linfa aveva un aspetto di cosa dolente; e quei fiori esili, un po’ carnicini, un po’ bianchi, simili a ciocche di rose scempie, che portavano un germe omai condannato, avevano all’aria un tremolio incessante.
Io dissi allora, come ad attenuare la crudezza di quella manomessione:
– È per Giuliana.
E, strappando le ultime fibrille vive, distaccai il ramo già rotto.
III
Non quel ramo solo portai a Giuliana, ma molti altri. Tornavo alla Badiola sempre carico di doni floreali. Una mattina, avendo su le braccia un fascio di spine albe, incontrai nel vestibolo mia madre. Ero un poco ansante, accaldato, agitato da una leggera ebrezza. Domandai:
– Dov’è Giuliana?
– Su, nelle sue stanze – ella rispose, ridendo.
Io feci di corsa le scale, attraversai il corridoio, entrai franco nell’appartamento, chiamai:
– Giuliana, Giuliana! Dove sei?
Maria e Natalia mi uscirono incontro con grandi feste, rallegrate alla vista dei fiori, irrequiete, folli.
– Vieni, vieni, – mi gridarono – la mamma è qui, nella camera da letto. Vieni.
E io varcai quella soglia palpitando più forte; mi trovai alla presenza di Giuliana sorridente e confusa: le gittai il fascio ai piedi.
– Guarda!
– Oh, che cosa bella! – esclamò, chinandosi sul fresco tesoro odorante.
Portava una delle sue ampie tuniche preferite, d’un verde eguale al verde d’una foglia d’aloe. Non ancóra pettinati, i suoi capelli erano mal trattenuti dalle forcine; le coprivano la nuca, le nascondevano gli orecchi, in dense matasse. L’effluvio della spina, un odor misto di timo e di mandorla amara, la investiva tutta, si diffondeva per la camera.
– Bada di non pungerti – io le dissi. – Guarda le mie mani.
E le mostrai le scalfitture ancóra sanguinanti, come per rendere più meritoria l’offerta. “Oh se ella ora mi prendesse le mani” pensai. E mi passò su lo spirito, vago, il ricordo di un giorno lontanissimo in cui ella mi aveva baciate le mani scalfite dalle spine e aveva voluto suggere le stille di sangue che spuntavano l’una dopo l’altra. “Se ella ora mi prendesse le mani e in questo solo atto mettesse tutto il suo perdono e tutto il suo abbandono!”
Io avevo di continuo, in quei giorni, l’aspettazione d’un momento simile. Non sapevo veramente da che mi venisse una tal fiducia; ma ero sicuro che Giuliana si sarebbe ridonata a me, così, o prima o poi, con un solo semplice atto silenzioso in cui ella avrebbe saputo mettere “tutto il suo perdono e tutto il suo abbandono”.
Ella sorrise. Un’ombra di sofferenza apparve sul suo volto troppo bianco, ne’ suoi occhi troppo incavati.
– Non ti senti un poco meglio, da che sei qui? – le domandai accostandomi.
– Sì, sì, meglio – ella rispose.
Dopo una pausa:
– E tu?
– Oh, io sono già guarito. Non vedi?
– Sì, è vero.
Quando mi parlava, in quei giorni, mi parlava con una esitazione singolare che per me era piena di grazia ma che ora m’è impossibile definire. Pareva quasi ch’ella fosse di continuo occupata a trattenere la parola che le saliva alle labbra, per pronunziarne una diversa. Inoltre, la sua voce era, se si può dir così, più feminile; aveva perduta la primitiva fermezza e una parte di sonorità; s’era velata come quella d’uno strumento con la sordina. Ma, essendo ella dunque verso di me in tutte le sue espressioni tanto mite, che cosa ancóra c’impediva di stringerci? Che cosa manteneva ancóra tra lei e me quell’intervallo?
In quel periodo che rimarrà nella storia della mia anima sempre misterioso, la mia nativa perspicacia sembrava interamente abolita. Tutte le mie terribili facoltà analitiche, quelle stesse che mi avevano dato tanti spasimi, sembravano esauste. La potenza delle facoltà inquiete pareva distrutta. Innumerevoli sensazioni, innumerevoli sentimenti di quel tempo mi riescono ora incomprensibili, inesplicabili, perché non ho alcuna guida per rintracciarne l’origine, per determinarne la natura. Una discontinuità, un difetto di fusione, è tra quel periodo della mia vita psichica e gli altri.
Udii una volta raccontare, nel corso di una favola, che un giovine principe, dopo un lungo pellegrinaggio avventuroso, giunse infine al conspetto della donna che egli aveva con tanto ardore cercata. Tremava di speranza il giovine, mentre la donna gli sorrideva da vicino. Ma un velo rendeva intangibile la donna sorridente. Era un velo d’ignota materia, così tenue che si confondeva con l’aria; eppure il giovine non poté stringere l’amata a traverso un tal velo.



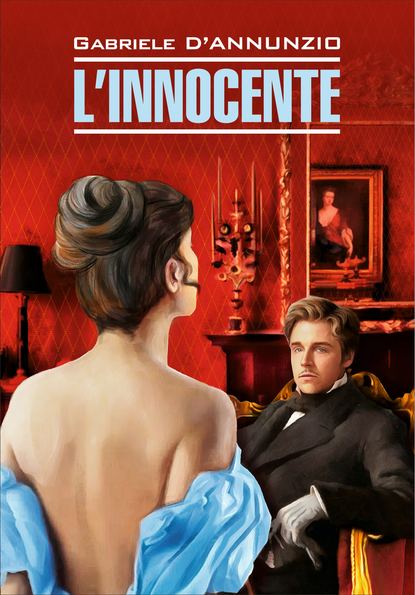




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0